Il doppio: caratteristiche nella letteratura
Il doppio come tema letterario è un concetto affascinante e ricco di sfaccettature. Questa tematica, ampiamente esplorata nel corso della storia letteraria, si riferisce all’idea di una dualità intrinseca nell’essere umano, spesso manifestata attraverso la presenza di un alter ego o di un gemello, sia reale sia immaginario. Il doppio può assumere varie forme e significati: può rappresentare il conflitto interiore tra il bene e il male, la lotta tra desiderio e dovere, o la divisione tra l’io pubblico e quello privato.
In letteratura, il doppio si manifesta frequentemente come un personaggio distinto ma profondamente legato al protagonista, riflettendo lati nascosti o repressi della sua personalità. Questo può servire come un potente strumento narrativo per esplorare temi profondi come l’identità, la moralità, la follia e il conflitto psicologico. La presenza di un doppio permette agli autori di esaminare le complessità dell’animo umano, sfidando i lettori a interrogarsi sulle verità nascoste che risiedono dentro di loro.
In alcune opere, il doppio può essere un’entità fisicamente separata ma emotivamente o psicologicamente connessa al personaggio principale. In altre, può essere un aspetto della mente del protagonista, una voce interna che esprime pensieri o desideri non riconosciuti. Questo aspetto può anche manifestarsi sotto forma di visioni, sogni o allucinazioni, aggiungendo un livello di mistero e ambiguità alla narrazione.
Andiamo più in profondità.
- Il doppio come espediente comico da Plauto a Shakespeare
- Il doppio come espediente comico
- Il doppio come forze interiori contrapposte - Stevenson
- Il doppio come realtà e apparenza a confronto: Oscar Wilde
- Il doppio come unicità umana: Il visconte dimezzato di Calvino
- Il doppio come atteggiamento politico: l’età giolittiana
- Il doppio come unità indissolubile: Trilogia della città di K di Agota Kristof
- Il doppio come evasione dalla realtà: l'esempio di Breaking Bad
- Continua la ricerca sul tema del doppio
Il doppio come espediente comico da Plauto a Shakespeare
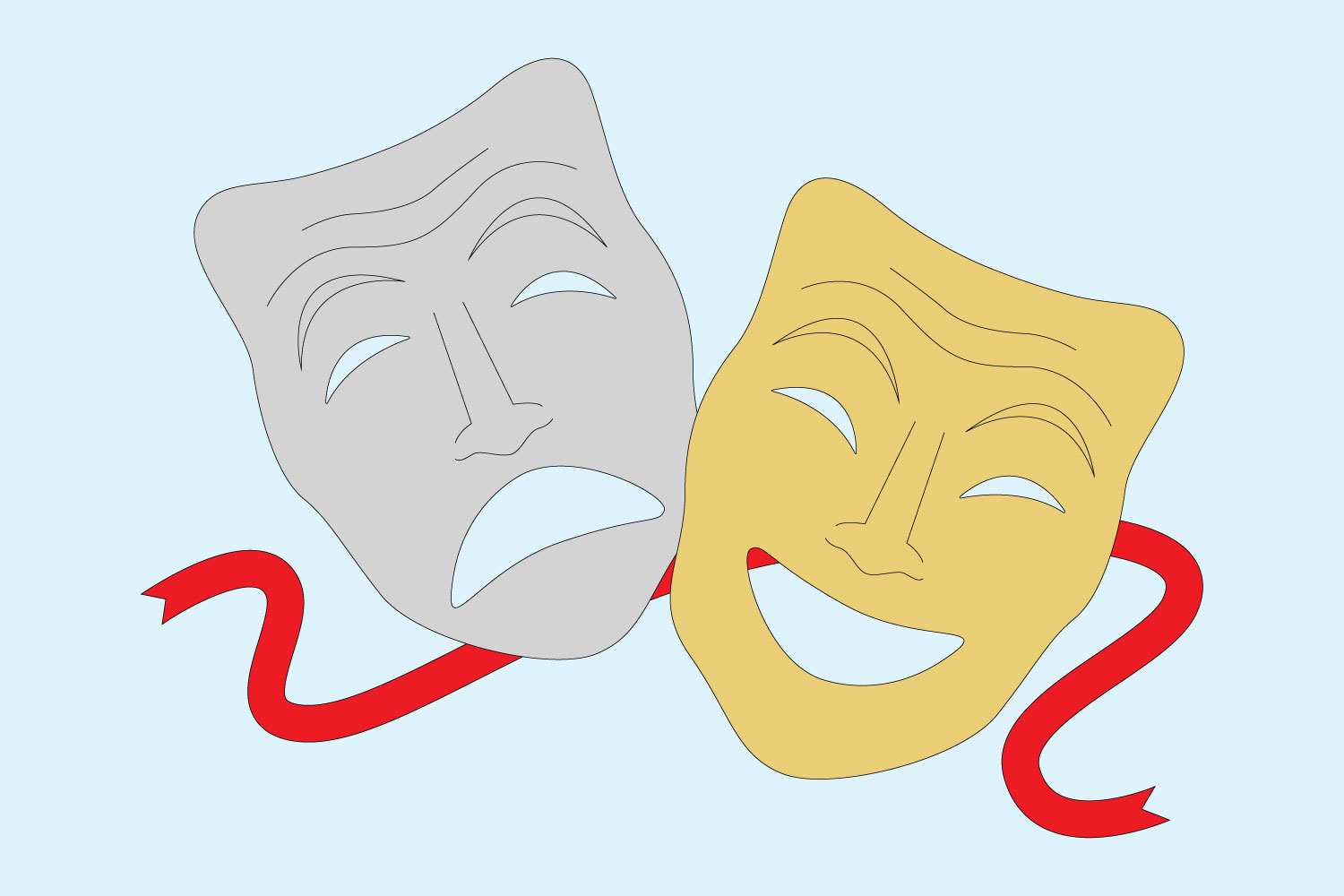
Commedia dell’equivoco per eccellenza, I Menecmi fu composta da Plauto, commediografo latino, nel III secolo a.C. circa. La storia ruota attorno a due gemelli identici, Menecmo I e Menecmo II. Alla sparizione del primo, segue il racconto delle peripezie che compie il secondo per ritrovarlo. Esilarante e satirica come ogni commedia plautina, l’opera costituisce per l’autore l’occasione per mettere in luce, e colpire, gli stereotipi sociali del suo tempo. In questo caso il doppio è un espediente teatrale volto a far divertire e confondere il pubblico. Non c’è alcuna volontà di far riflettere lo spettatore sulla complessità dell’animo e dell’identità umana.
Il modus operandi plautino fu in seguito ripreso e notevolmente esasperato da William Shakespeare ne La commedia degli errori, opera teatrale della fine del Cinquecento nella quale si mettono in scena ben due sparizioni; siamo di fronte a uno sviluppo della tematica del gemello perduto, elevato alla seconda. Infatti la commedia pone gli spettatori di fronte a due coppie di gemelli separati: due servi gemelli e rispettivi padroni, anch’essi identici. Se l’ambiguità generata da Plauto era fonte di divertimento e ilarità per il suo pubblico, in questo caso la confusione e il riso sono esponenziali. Anche qui il tema del doppio è strettamente connesso a quello dell’equivoco che guida la comicità della scena. Ancora una volta, nell’opera del drammaturgo inglese non si percepisce alcuna volontà di indagare la profondità della psiche umana, limitandosi a inserirsi all’interno di una tradizione già iniziata da Plauto.
Il doppio come espediente comico
Genitori in trappola (1998): di produzione Disney, il film racconta la storia di due gemelle divise fin da piccole in seguito alla separazione dei genitori. A 12 anni le due ragazze hanno l’occasione di incontrarsi casualmente in un campo estivo e, svelata la loro somiglianza e parentela, decidono di scambiarsi i ruoli. In questo modo non solo si concedono reciprocamente la possibilità di conoscere l’altro genitore, che non hanno mai avuto modo di incontrare, ma sperano di potersi ritrovare, costituendo un’unica famiglia. L’agnizione finale porterà i rispettivi genitori a riconoscere il trucco e a riallacciare i rapporti.
Il film è una piacevole commedia degli equivoci e, come per le opere citate in precedenza, la tematica del dissidio interiore umano è completamente assente.
Due curiosità:
- Nell’interpretazione delle due gemelline si è lanciata un’unica attrice, Lindsay Lohan. Questa doppia performance ha rappresentato il suo debutto cinematografico.
- L’opera rappresenta il remake del film Il cowboy con il velo da sposa e non è l’unico: tre anni prima era già uscito sui grandi schermi Matrimonio a 4 mani, trampolino di lancio per le gemelle Olsen.
Il doppio come forze interiori contrapposte – Stevenson
È nell’Inghilterra vittoriana che il tema del doppio inizia ad assumere connotazioni psicologiche più profonde, grazie alla penna e all’ingegno di Robert Luis Stevenson.
Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886) pone i suoi lettori di fronte a una consapevolezza: all’interno di ogni essere umano convivono bene e male. I protagonisti del racconto sono uno l’alter ego dell’altro. Spinto dalla curiosità e dal desiderio di separare queste due forze motrici contrapposte, Dr. Jekyll collauda una pozione, che porta alla creazione di Mr. Hyde (il cui nome, dall’inglese, richiama il concetto di nascosto). Come si comprende nel corso della lettura, questa identità malvagia avrà tuttavia la meglio sulla buona, riuscendo a sopraffarla al punto che al dottore non resterà che soccombervi, togliendosi la vita.
Attraverso questo racconto, Stevenson anticipa la teorizzazione freudiana di Eros e Thanatos, delle due forze contrapposte di cui la mente umana è allo stesso tempo vittima e moderatrice. In questo caso il tema del doppio riflette la dualità intrinseca alla psicologia umana.
Dr. Jekyll si mostra di giorno come un uomo stimato e rispettabile dalla società del suo tempo, mentre la notte, nelle vesti di Hyde, compie i peggiori delitti, venendo meno la sua sottomissione alle imposizioni sociali.
L’opera rappresenta una critica nei confronti dell’ipocrisia della società vittoriana della fine dell’Ottocento, una società fatta di finto perbenismo, inganni e apparenze.
Il doppio come realtà e apparenza a confronto: Oscar Wilde
Il ritratto di Dorian Gray (1891) di Oscar Wilde è di poco successivo: insieme alla tematica del doppio, l’autore denuncia l’ossessione per l’immortalità e per il concetto di bellezza espresso dall’estetica. Il doppio in questo caso è incarnato da un oggetto esterno, un’opera d’arte: infatti il protagonista riceve come dono un quadro che lo raffigura nella sua lucente giovinezza e bellezza.
Prima di questo momento Dorian Gray non aveva mai riflettuto a fondo sul suo aspetto fisico e sulla sua bellezza. Ora, posto di fronte all’evidenza, ne riconosce la grandezza e l’importanza valoriale. Se da una parte il quadro gli infonde maggiore sicurezza, dall’altro lo intimorisce, riconoscendo che bellezza e giovinezza sono temporanei e provvisori. Decide quindi di stringere un patto con l’opera d’arte, che invecchierà e si imbruttirà al posto suo.
Apparenza e realtà sono messe a confronto: attraverso il dono dell’opera d’arte, Dorian Gray realizza che l’immagine che ha di sé non corrisponde al modo in cui lo vedono gli altri. Il tutto troverà ampio spazio nella letteratura pirandelliana.
Il doppio come unicità umana: Il visconte dimezzato di Calvino

Il visconte dimezzato (1952) di Italo Calvino si inserisce nella tradizione delle opere precedenti, rinnovandola dal suo interno. Se da Stevenson viene ripresa la tecnica dello sdoppiamento, tale processo avviene qui solo per metà: il protagonista viene colpito in guerra da una palla di cannone che lo separa in due metà fisiche ed etiche. Una metà è buona, mentre l’altra incarna l’orrore dell’umanità.
Tuttavia sarebbe sbagliato ridurre l’opera calviniana a questa lettura superficiale e binaria: l’intento dell’autore consiste nella volontà di riflettere sulla vera identità dell’essere umano. La divisione di cui Medardo è vittima diventa, per l’autore, allegoria dell’uomo contemporaneo, incompleto, nemico a se stesso. Secondo Calvino tutti gli uomini si sentono in qualche modo incompleti, dedicandosi e realizzando soltanto una parte di sé, trascurando l’altra.
Nessuna delle due metà riesce infatti a beneficiare dell’incidente: entrambi i mezzi uomini provano rabbia e ostilità nei confronti dell’altro. Dunque, non è soltanto la parte malvagia a dare il peggio di sé, ma anche quella buona, che a livello ipotetico potrebbe sembrare la migliore, non è comparabile all’individuo nella sua integrità.
Questo viene dimostrato anche dal fatto che nessuno dei due Medardi esce vittorioso dallo scontro finale, anzi, è soltanto grazie a questo che il visconte torna a essere intero.
Fuori di metafora, dunque, l’uomo per considerarsi completo deve essere turbato dal conflitto tra bene e male, che ne costituisce proprio la peculiarità.
Leggi il finale dell’opera calviniana. Per stampare il testo, scarica il PDF qui:
Il doppio come atteggiamento politico: l’età giolittiana
Divenuto ministro del Consiglio nel 1903, Giovanni Giolitti mantenne il suo incarico fino al 1914. In campo politico, il suo modo di agire fu caratterizzato da una profonda contraddizione interna, ricordata con l’espressione “del doppio volto”.
Infatti, se manifestò un atteggiamento attento e tollerante nei confronti del mondo operaio del Nord Italia, autorizzando scioperi e varando riforme volte a migliorarne le condizioni di lavoro, dall’altro lato, adottò un comportamento conservatore e corrotto nello sfruttare i problemi che dilaniavano il Sud. Questo gli valse l’appellativo di ministro della malavita. Nel Meridione, infatti, credeva fosse giusto mantenere il pugno duro, senza stabilire alcuna linea di dialogo.
Questo duplice atteggiamento non fece che accentuare la già visibile sproporzione tra Nord e Sud: sulla scia dell’ormai inarrestabile sviluppo industriale, nel Settentrione si rilevarono un notevole miglioramento del livello di vita e la diffusione di un considerevole benessere economico, contrapposto alla mancanza di lavoro e allo spopolamento che imperversava nel Sud del Paese.
Il doppio come unità indissolubile: Trilogia della città di K di Agota Kristof
Trilogia della città di K di Agota Kristof è un romanzo di non nomi e non luoghi. Ci troviamo in un non bene precisato paese dell’Est dilaniato dalla guerra. Al centro della scena ci sono due bambini, gemelli. L’opera si compone di tre libri e già dal primo l’autrice, attraverso uno stile asciutto e incisivo, instilla nella mente del lettore un dubbio: si tratta davvero di due gemelli o di un unico personaggio? La voce narrante assume tratti quasi corali al punto da domandarsi se si tratti di un’unica effettiva entità inscindibile.
Alla fine di questo primo libro, tuttavia, questa unità inseparabile si scinde: uno dei gemelli varca la frontiera, lasciando il villaggio nel quale ha vissuto sotto assedio dei militari, mentre il secondo rimane, per curare i possedimenti della nonna.
Le emozioni e le sofferenze differenti che vivono, e superano, li portano dunque a discostarsi, al punto che il lettore comincia a interrogarsi se l’affiatamento che ha percepito inizialmente sia realmente esistito.
La lettura di questo libro è stata consigliata anche da Camihawke nel suo bookclub su Instagram.
Il doppio come evasione dalla realtà: l’esempio di Breaking Bad
Breaking Bad (2008-2013) è una serie tv statunitense, volta a dimostrare come vicissitudini e imprevisti esterni possano modificare irreparabilmente la morale e il comportamento di ciascun umano.
Walter White è un professore di chimica del liceo che vive una vita ordinaria e mediocre. Ha una moglie, un figlio adolescente con paralisi cerebrale e una seconda figlia in arrivo, del tutto inattesa. L’equilibrio familiare, di per sé precario, viene sconvolto da una diagnosi di tumore ai polmoni, con un’aspettativa di altri 18 mesi di vita.
Inizialmente spinto da motivi apparentemente altruistici, come il desiderio di garantire un’adeguata stabilità economica alla sua famiglia anche in sua assenza, Walter comprende che non ha nulla da perdere: vuole sfruttare le sue conoscenze chimiche per produrre anfetamina e aumentare i propri guadagni. Inoltre, la sensazione di essere una vittima innocente accompagna il protagonista lungo tutto il suo percorso criminale, motivandolo.
Il professore di chimica, che sembra aver perso il controllo della sua vita, diventa Heisenberg, che del controllo meticoloso fa una delle sue più grandi peculiarità. Nelle vesti di quest’ultimo, i suoi modi di fare sgraziati e impacciati spariscono, soppiantati da comportamenti autoritari e risoluti. Le mancanze di White sono colmate da Heisenberg, in una totale assenza di moralità e ragione. La coesistenza di queste identità sarà tuttavia portata al collasso.
Fun fact:
- Il termine Breaking bad è un’espressione colloquiale del sud degli USA che si rivolge a qualcuno che ha perso la bussola e che, per un giorno o una vita intera, si allontana dalla retta via.
- La serie tv è stata pensata e studiata a tavolino. La volontà di girare 5 stagioni non è nata a seguito del successo della prima, ma è il frutto di un progetto unitario.
Continua la ricerca sul tema del doppio
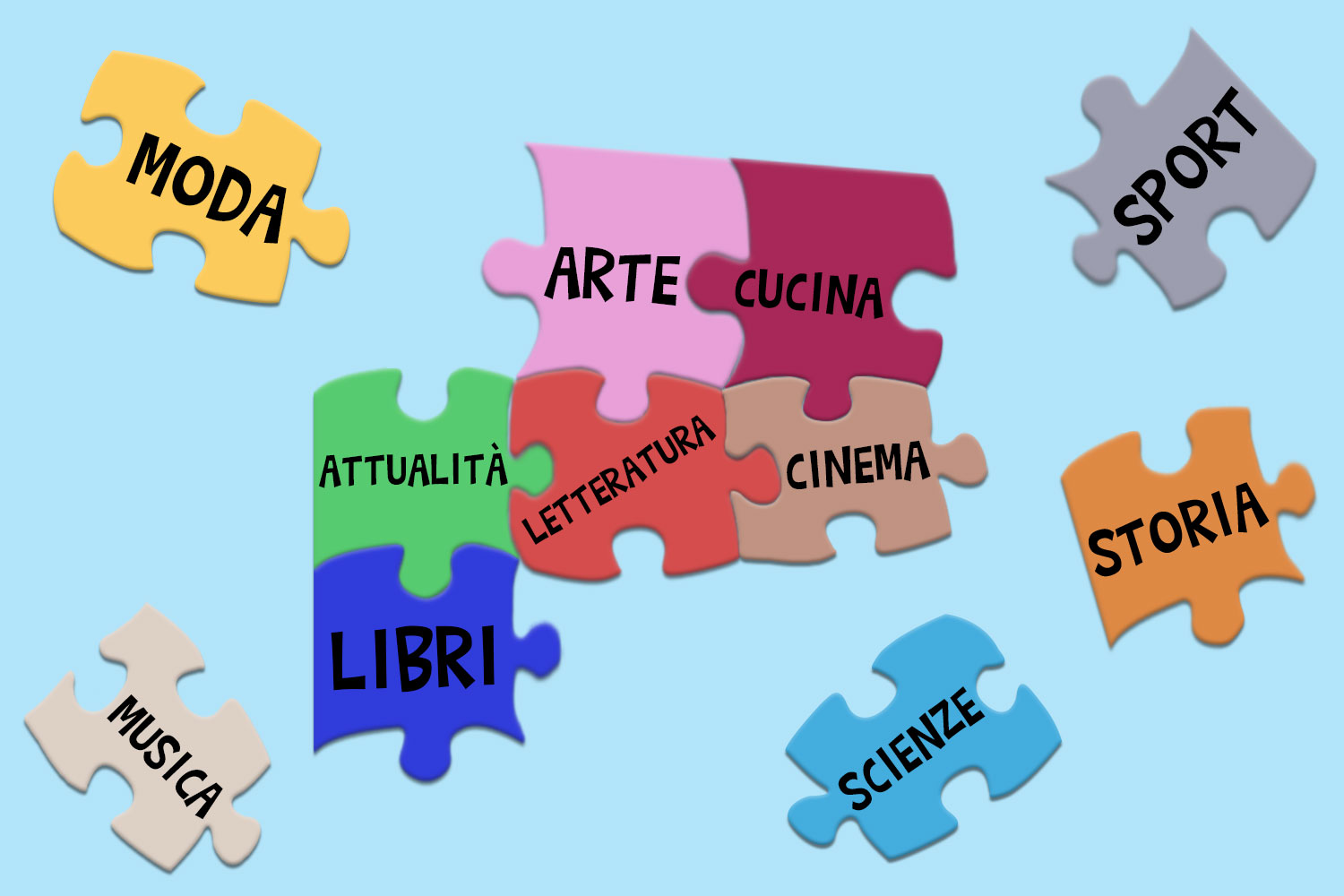
Pensi che la trattazione del tema del doppio si possa concludere qui? Ora la palla passa a te: sulla base di ciò che hai trattato in classe, ma anche delle tue passioni e di input esterni, da’ un’impronta personale al percorso. L’esercizio si presta perfettamente anche per un lavoro di gruppo.
Ami le serie tv? Guarda Mr. Robot: confrontati con i tuoi compagni, si può ancora parlare di fenomeno di sdoppiamento o ciò che attraversa il protagonista è una vera e propria disgregazione di identità?
Hai il pallino per la fisica? Affronta il tema del doppio nell’ottica di “polo positivo” e “polo negativo”.
Stai in fissa con biologia? Cosa sai degli studi condotti sulla clonazione?
Famiglia appassionata di musica? Ecco l’occasione per far conoscere David Bowie e il suo alter ego Ziggy Stardust anche ai tuoi compagni.
Ami l’arte contemporanea? Approfondisci la conoscenza dell’opera di Alighiero Boetti che a un certo punto della sua vita ha iniziato a firmarsi come Alighiero e Boetti.
Ti interessa la cucina? Cosa sai dei cibi a doppia consistenza? Divertiti a sperimentare nuove ricette.
