Tema sul rapporto tra uomo e ambiente
Nel corso degli ultimi decenni, il rapporto tra uomo e ambiente è diventato uno dei temi centrali del dibattito pubblico e accademico, spinto soprattutto dall’urgenza dei cambiamenti climatici.
Il cambiamento climatico, inteso come una modificazione significativa e duratura dei modelli climatici terrestri, attribuita in larga misura all’attività umana post-industriale, rappresenta una delle sfide più complesse del nostro tempo. L’impatto di tale fenomeno si estende ben oltre le sole considerazioni meteorologiche o ambientali, toccando aspetti economici, sociali, politici e culturali della vita umana.
Una comprensione completa di questa crisi richiede un approccio interdisciplinare, che integri conoscenze e metodi di diverse discipline. Nella storia, ad esempio, l’analisi dei cambiamenti climatici può offrire spunti sulle cause e le conseguenze di eventi passati, come periodi di grande prosperità o di decadenza di civiltà, in relazione alle condizioni ambientali dell’epoca.
Vediamo insieme come questi temi possono essere utilizzati per scrivere un tema sul rapporto tra uomo e ambiente.
- Uomo e ambiente nella storia: la rivoluzione industriale
- Uomo e ambiente in arte: le illustrazioni di Gustave Doré
- Uomo e ambiente in letteratura: la Londra vittoriana
- Uomo e ambiente in musica: "Là dove c’era l’erba ora c’è una città"
- Uomo e ambiente: clima e attualità
- Continua la ricerca sul rapporto tra uomo e ambiente
Uomo e ambiente nella storia: la rivoluzione industriale
Nella storia, l’analisi dei cambiamenti climatici può offrire spunti sulle cause e le conseguenze di eventi passati, in relazione alle condizioni ambientali dell’epoca. Basti pensare alla Prima Rivoluzione Industriale, con la quale si assiste a un effettivo sconvolgimento nella produzione dei beni di consumo e nella metodologia di produzione. Tuttavia l’apporto rivoluzionario dell’evento è tangibile anche in senso più ampio, a livello sociale, determinando il passaggio all’inurbamento, il trasferimento della popolazione nell’ambito territoriale e sociale, a discapito del lavoro nelle campagne.
Con la costruzione delle prime fabbriche il contadino abbandona la vita rurale e diventa operaio. A questo cambio di prospettiva segue una nuova organizzazione territoriale: l’attività lavorativa si concentra progressivamente nei centri urbani. Anche le campagne circostanti risentono di questa trasformazione e, di fronte a una popolazione urbana in aumento, modificano le proprie colture per ottimizzarne la produzione.
Segue la Seconda Rivoluzione Industriale, che introduce l’utilizzo su larga scala dell’elettricità e del petrolio, segnando l’ascesa dell’industria pesante e della produzione di massa. Questo periodo porta con sé una maggiore capacità produttiva e un’ulteriore accelerazione dell’urbanizzazione, ma anche un incremento significativo dell’impronta ambientale umana. Le emissioni di gas serra aumentano esponenzialmente, contribuendo all’inizio del cambiamento climatico antropogenico, ovvero causato direttamente o indirettamente dalle attività umane.
Uomo e ambiente in arte: le illustrazioni di Gustave Doré
Nella Londra di fine Ottocento è ancora troppo presto per parlare di questione ambientale, ma sin da subito si comprende la gravità dei fumi delle ciminiere per l’organismo umano. Si pensa ingenuamente che per risolvere il problema basti costruire ciminiere più alte, ottenendo l’effetto opposto: le polveri si depositano a un raggio ancora più ampio.
In quel periodo, diversi artisti decidono di restituire un’immagine a tutto tondo delle ripercussioni della rivoluzione industriale nelle proprie città. In particolare, le illustrazioni di Gustave Doré offrono una rappresentazione visiva straordinariamente eloquente dell’impatto della Rivoluzione Industriale sulla Londra dell’epoca.
“London: A Pilgrimage” è un’opera monumentale realizzata dal celebre illustratore francese in collaborazione con il giornalista Blanchard Jerrold, pubblicata per la prima volta nel 1872. L’opera si propone come un viaggio attraverso le diverse facce di Londra, dalle zone più eleganti e aristocratiche fino agli angoli più oscuri e degradati della città. Con un gioco di luci e ombre quasi teatrale, l’artista mette in scena la nebbia di carbone che avvolge la città, ormai simbolo dell’inquinamento atmosferico.
Le strade affollate di Londra, con le loro masse in movimento, riflettono la disumanizzazione e l’alienazione provocate dall’urbanizzazione rapida e incontrollata. Doré, presentando scene di vita quotidiana, ritratti di personaggi e panorami urbani, utilizza la profondità e la densità delle sue incisioni per sottolineare il divario crescente tra ricchezza e povertà, tra l’ambiente naturale e quello trasformato dall’uomo.
In questo modo, l’arte di Doré diventa un potente commento visivo sulle ripercussioni ambientali e umane della Rivoluzione Industriale, evidenziando la complessa interazione tra uomo e ambiente nell’era industriale.
Uomo e ambiente in letteratura: la Londra vittoriana
La letteratura ha da sempre offerto uno spazio privilegiato per esplorare il complesso rapporto tra uomo e ambiente. Attraverso le pagine dei romanzi, delle poesie e dei racconti, gli scrittori hanno riflettuto sulle interazioni tra la natura e le società umane, dalle armoniose convivenze alle profonde fratture causate dall’industrializzazione e dall’espansione urbana.
Questo tema letterario si estende alle rappresentazioni critiche delle distopie industriali e post-industriali, che mettono in luce le conseguenze ambientali e sociali dello sviluppo tecnologico.
Charles Dickens e la sua Coketown
L’urbanizzazione, da processo storico, trova presto una sua rappresentazione letteraria nell’autore inglese Charles Dickens. Conscio della propria funzione sociale e civile, la scrittura acquista per Dickens un fine didattico ed educativo.
Il suo passato da reporter gli permette di offrire ai suoi lettori una rappresentazione fedele e realistica della realtà. La sua figura è scomoda e le immagini che descrive spiacevoli: pone le classi più agiate di fronte alla miseria umana di cui sono completamente inconsapevoli.
Nel 1854 l’autore pubblica Hard Times, opera nella quale critica la miseria del lavoro in fabbrica, la degradazione delle classi più umili e il materialismo su cui si fonda l’intera società vittoriana. Fuori dalla fabbrica, le classi più agiate beneficiano dei prodotti che vi si realizzano, eppure sono del tutto inconsapevoli della condizione degli operai e la povertà in cui imperversano li imbarazza.
In questo romanzo, la città immaginaria di Coketown rappresenta l’archetipo della città industriale dell’epoca, caratterizzata da fabbriche fumanti, edifici monotoni e un ambiente soffocante, sia fisicamente che metaforicamente. Dickens utilizza Coketown non solo come sfondo per la narrazione, ma anche come personaggio a sé, criticando apertamente l’industrializzazione sfrenata e l’impersonalità delle relazioni sociali che ne derivavano, sottolineando la necessità di un approccio più umanistico e compassionevole alla società industriale.
Coketown incarna gli aspetti negativi dell’industrializzazione: lunghe ore di lavoro, scarsa qualità della vita e inquinamento ambientale. È una città interamente basata sulla produzione, monitorata in maniera ossessiva attraverso dati e statistiche. Per gli operai, ogni giorno è uguale all’altro: non c’è differenza neppure tra il cimitero in cui si muore e l’ospedale in cui si nasce.
Il brano che segue, tratto dal romanzo Hard Times, è un estratto della descrizione di Coketown. Per stampare il testo scarica il PDF qui:
I penny dreadful
Se Dickens identifica le classi più agiate come le dirette destinatarie dei suoi romanzi, esiste tuttavia una fonte di intrattenimento ancora più economica rivolta alle classi più umili: i penny dreadful. Sono brevi romanzi horror distribuiti settimanalmente nel XIX secolo che, al costo di una sola moneta, offrono ai lettori storie terrificanti. Nonostante queste pubblicazioni rivelino delle pecche nella trama, intrecciano origini di personaggi della letteratura horror, come Frankenstein, il conte Dracula e Dorian Gray.
Si tratta dunque di brevi racconti, privi di alcuna ambizione letteraria, incentrati su crimini e indagini macabre e sanguinose. Tuttavia, la diffusione di questo nuovo genere narrativo tra i più poveri appare agli occhi della classe dominante un’ammissione di criminalità, a cui segue una vera e propria condanna.
Nella serie tv omonima, Penny Dreadful, i personaggi, alcuni dei quali rappresentano dei classici della letteratura, si inseriscono nel contesto sociale a loro contemporaneo della Londra vittoriana, rivelandone le caratteristiche a chi non conosce l’epoca.
Uomo e ambiente in musica: “Là dove c’era l’erba ora c’è una città”
Sotto la spinta della Seconda Rivoluzione Industriale, la scelta di abbandonare le campagne “in cerca di fortuna” sarà un motivo ricorrente anche nel secolo successivo.
È appunto agli inizi del Novecento che facciamo risalire i fenomeni di urbanizzazione e concentrazione. In città si concentrano persone, edifici, mezzi di trasporto e vie di comunicazione, ma anche la maggior parte delle attività umane e degli scambi di beni e informazioni.
All’interno dei centri urbani la società assume una struttura definita: ogni bisogno o esigenza del singolo può trovare il suo soddisfacimento all’interno della città stessa. Siamo di fronte a un organismo autosufficiente. Questo tuttavia non viene letto dall’uomo con soddisfazione, ma viene vissuto con un senso di oppressione.
Negli stessi anni in cui Calvino esprime questo senso di disorientamento attraverso la figura di Marcovaldo, sui giradischi nelle case degli italiani suona Adriano Celentano.
Il ragazzo della via Gluck (1966) racconta la prepotenza di una città che inghiotte la campagna, distruggendone la bellezza. Secondo Celentano, “difendere la natura non può che essere rock” ed è questo che fa il protagonista della canzone: con il cuore spezzato lascia la campagna e la vita all’aria aperta, per “respirare il cemento del centro”. L’unica consolazione è la prospettiva di un futuro più roseo e la possibilità di poter tornare un giorno a casa. Con grande amarezza tuttavia anche in campagna l’erba lascia il posto al progresso: “La dove c’era l’erba ora c’è una città”, afferma il ritornello, “e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?”.
Uomo e ambiente: clima e attualità
Dal 1850 a oggi la temperatura media sul pianeta Terra è aumentata di circa 1°C. Questo cambiamento non ha lasciato indifferente flora e fauna terrestre.
Ma come possiamo ricondurre lo scioglimento dei ghiacciai, il progressivo cambiamento dei comportamenti animali e persino la fioritura anticipata di alcune piante all’intervento umano?
A qualsiasi azione dell’uomo corrisponde un’emissione in atmosfera di determinati composti inquinanti che alterano il clima. Tali emissioni hanno subito una repentina accelerazione dalla Prima Rivoluzione Industriale, prima con il carbone e successivamente con il petrolio. Da allora infatti, con i processi di combustione sempre più invasivi, vi è stato un cambiamento sostanziale della composizione dell’atmosfera.
Cosa si intende per cambiamento climatico e come affrontarlo consapevolmente? A confrontarsi sul tema, Giulia Trincardi e Sofia Viscardi. Guarda il video per approfondire:
Consigli di lettura
E se ti dicessero che per salvare l’ambiente basta ridurre il consumo di carne, saresti disposto a farlo? Questa è la proposta di Jonathan Safran Foer in Possiamo salvare il mondo prima di cena (2019).
Nessuno spassionato appello al veganesimo, ma un dato di fatto: ridurre il consumo di carne e di derivati animali a un giorno a settimana può salvare l’ambiente. Il libro indaga le origini della crisi climatica offrendo al lettore spunti di cambiamento. Attraverso una raccolta di dati esaustiva, Safran Foer lo esorta ad adottare uno sguardo critico nei confronti delle azioni che (non) è abituato a svolgere per il mondo. Nessun lavaggio del cervello, nessun regime del terrore, soltanto il suggerimento a riflettere sulle proprie abitudini alimentari.
Continua la ricerca sul rapporto tra uomo e ambiente
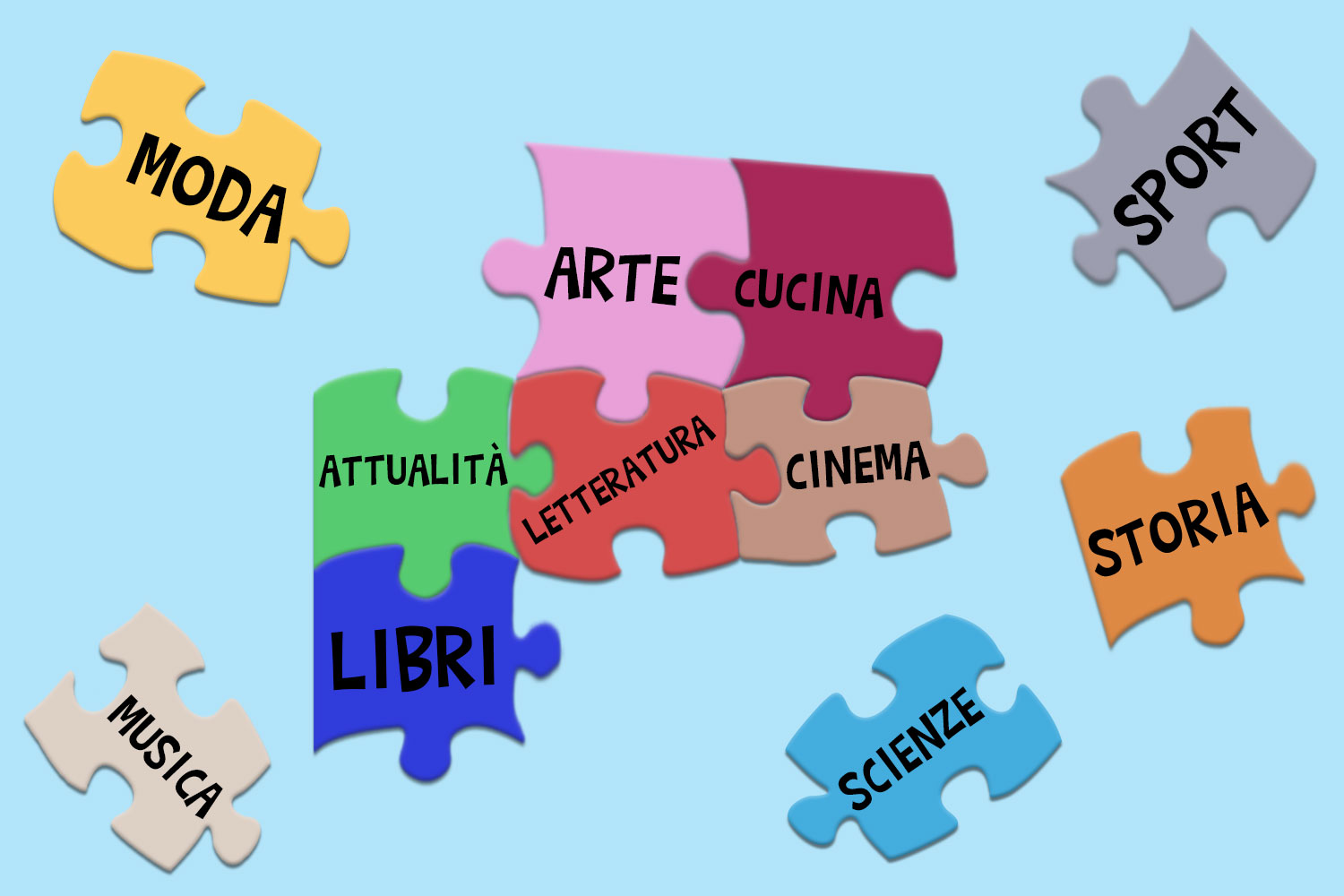
Pensi che la trattazione della relazione tra uomo e ambiente e della crisi climatica sia esaurita? È il tuo turno: sulla base degli argomenti trattati in classe, ma anche delle tue passioni e dei tuoi interessi, puoi dare un’impronta personale al percorso. L’esercizio si presta perfettamente anche per un lavoro di gruppo.
Amante della palestra e seguace di una dieta rigida? Lo sapevi che le nostre scelte alimentari hanno conseguenze sull’ambiente? Game Changers è un documentario che smentisce i molti luoghi comuni sulla correlazione tra performance fisica e dieta iperproteica.
Hai una passione per il motorsport? Cosa sai dell’Extreme E? Pensi che la rivoluzione ecologica riuscirà a imporsi nelle competizioni automobilistiche?
Fan di Ludovico Einaudi? Qual è il messaggio sotteso a Elegy for the Arctic? Pensi che la musica possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica?
Appassionato di arte? Scopri come Arte e Scienza possano convivere nei lavori di Anne de Carbuccia nelle lezioni One Planet, One Future.
Instagram dipendente? Tieni presente l’esistenza dell’inquinamento digitale. Per saperne di più, scopri cosa si intende per “Buongiornissimo”.
E se vuoi restare aggiornato sulla questione climatica, non perderti gli ultimi aggiornamenti sulla Cop26.
